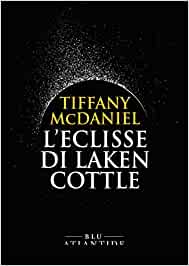Space Invaders di Nona Fernández è un libro sulla memoria dei bambini, quando questa memoria è forclusa, cioè irrecuperabile, schiacciata dall’indicibile di una dittatura. I protagonisti sono stati bambini e compagni di classe durante la dittatura di Pinochet. La dittatura è questo buco nero che resta invisibile, perché attrae a sé e divora quella luce che è condizione atmosferica di ogni esperienza del mondo. È un evento dalla densità infinita di silenzio e di orrore, ma l’autrice non racconta la storia, non ne rende testimonianza, ci mostra solo l’effetto di sfondamento che esso ha prodotto nel tessuto della mente, e al tempo stesso l’attrazione che esso esercita, facendo orbitare irrevocabilmente le memorie dei bambini intorno a sé. Memorie che sono state frantumate nel momento stesso della loro formazione, e sono destinate a restare così, schegge, relitti, che non possono ricomporsi perché mai sono stati integri, solo ripetere come satelliti di una stella disgregata, la loro obbediente rotazione intorno al buco nero.
Il buco nero prende una forma, un nome, quello della bambina Estrella Gonzalez, figlia di un pezzo grosso del regime. Il tempo di iniziare la scuola, rispondere all’appello – e tutti i bambini qui si chiamano solo per cognome, come fossero in ogni istante convocati e messi in fila da una voce imperiosa – e Gonzalez sparisce, trascinata in giro per il mondo dalle vicissitudini del padre, dal tradimento e dall’omertà dei suoi sodali, come si intuisce. Lei gioisce di questa giostra luminosa che le appare il mondo, scrive ingenuamente lettere entusiaste all’amica, lettere che a un certo punto sono troncate dalla censura imposta dagli adulti. Riappare fugacemente in un articolo di giornale conservato negli archivi della scuola, e il suo nome finalmente viene detto, anzi urlato dal marito geloso, anch’egli tenente dei famigerati Carabineros di Pinochet, prima del femminicidio. Oltre le cesure della storia, si prolunga l’odio, la paranoia, la disponibilità di armi mortali, ma tutto ciò non può essere detto, ed Estrella non può prendere carne e sostanza neppure nella morte, “si disarticola in luci colorate” come i marziani del videogioco che dà il titolo al libro. Nel videogioco la morte è costantemente ripetuta e mai definitiva, è possibile giocarsi nuove esistenze, ma non vincere una volta per tutte e andare oltre. Soprattutto, neanche col sacrificio di una vita, il suo esplodere e sparire in un fuoco effimero di pixel, si può battere il punteggio che le generazioni precedenti, i fratelli innominabili morti da eroi in battaglia, avevano raggiunto.
La memoria dell’infanzia è come un sogno che ci narriamo e ci rinarriamo. Tutti i ricordi della nostra vita sono ricostruiti in una continua affabulazione, in cui il senso raggiunto proietta all’indietro la sua luce, e il passato è la stoffa cangiante di cui siamo fatti. I ricordi dell’infanzia sono particolari, perché la loro consistenza è più aerea e cedevole. Sono nubi dalle mille forme, che precedono il gioco dell’immaginazione. Ma per questi bambini il sogno è solo la materialità soffocante dei materassi e delle lenzuola che indicano come proprie dimore. Risucchiati dal sonno come da un vortice di sabbia senza fine, cercano con fatica di ricostruire ciò che è stato. Gonzalez, la sparita, l’assente, la mai veramente morta, è colei che come una spoletta guizza dall’uno all’altro, visitandoli nei sogni come volesse intessere e riparare la tela lacerata della memoria. A qualcuno appare come voce, ad altri parla in forma di lettere, con verbosità e impertinenza di bambina, a Zuñiga, il destinatario di un’infatuazione segreta, appare nel suo corpo nudo impregnato di acqua marina, lo rassicura sulla sua vittoria, chiede perdono per la propria innocenza. Le sue fattezze mutano, il nome è incerto, l’età sembra oscillare, come se ognuno faticosamente cercasse di trattenere una sfaccettatura del suo essere. Ma questi pezzi non si incastrano mai, non corrispondono, sono solo barbagli di luce radente che sezionano la memoria. Come nel gioco segreto che essi stessi avevano inventato, i bambini eterni si cercano nel buio, si pizzicano, si accarezzano, si abbracciano e poi si perdono in una risata cristallina. Ma quando gli adulti riaccendono la luce, si sono già ricomposti nell’ordine rituale e implacabile dei corpi imposto dalla disciplina. I riti della propaganda, l’inno nazionale, la bandiera, le file ordinate, ciascuno con la mano sulla spalla del compagno di fronte, l’igiene delle uniformi, l’esattezza ritmica dei bottoni infilati nelle asole, questo è l’unico passato che torna, ossessivo e sempre uguale, man mano che i decenni passano. È lo spettro di un’infanzia indicibile, di una verità che non poteva mai essere interrogata, a turbare l’ininterrotto dormiveglia di questi sopravvissuti. Trattenuti in un’infanzia che non può essere mai trascesa, perché il passato non è mai trascorso. I bordi delle cose sono inafferrabili perché scheggiati e taglienti, e dall’eterno ritorno del trauma, dalla sua giostra feroce, ormai nessuno può scendere. Non saranno mai adulti, ma solo sonnambuli tormentati dai flash, e ogni breve risveglio è solo la dolorosa coscienza che il tempo è trascorso a scatti, senza di loro. Possono invecchiare, non possono crescere.
Ne Il fiore rosso e il bastone, Herta Müller rievoca in modo sorprendentemente simile l’infanzia rubata degli scolari nella Romania di Ceaușescu. Lo stesso buco nero li trascina e li disfa, la cesura e lo strappo, l’eterno ritorno della vergogna ingiustificabile per ciò che non si è compreso. Il tempo, scrive Müller, “non va errando cronologicamente attraverso la memoria, ma si espande nelle tante sfaccettature del ricordo. S’incontrano sempre nuovi particolari, s’accoppiano in modo nuovo, e a ogni accoppiamento assumono un aspetto diverso. La testa è il luogo di saccheggio della dimensione più bassa delle cose.” Solo gli oggetti restano, ti assediano, ti abbagliano, come le file di alieni verdi riavviano continuamente il gioco che non puoi vincere. L’oggetto infestante che perseguita i sogni dei bambini di Nona Fernandez sono le mani artificiali del padre di Gonzales, che è stato amputato, forse, durante una battaglia, come dice la verità ufficiale. Mani di legno, di argento, armate di artigli e pallottole, che brulicano come insetti nella mente, invadono le loro case dalle troppe porte chiuse. La vita passa nel sussulto dei falsi risvegli, nell’improvviso affollarsi delle sparizioni, delle bare e dei fiori. La vita di una generazione fatta della verde fosforescenza degli schermi, di un’invasione aliena che non ha fine (ma chi è l’alieno, chi è l’altro da uccidere qui?), dell’attesa di una chiamata che li convoca ancora e ancora, i corpi troppo cresciuti per le strette uniformi. La chiamata di Gonzalez che da qualche luogo ignoto oltre la vita dovrebbe infine rivelare il vero, ricondurli alla realtà dietro gli spettri ingannevoli dell’ideologia, ma che ogni notte li lascerà così, imperdonati e imperdonabili, bambini eterni nel vortice del tempo.
Nona Fernández
Space Invaders
Edicola Ediciones, Ortona 2015